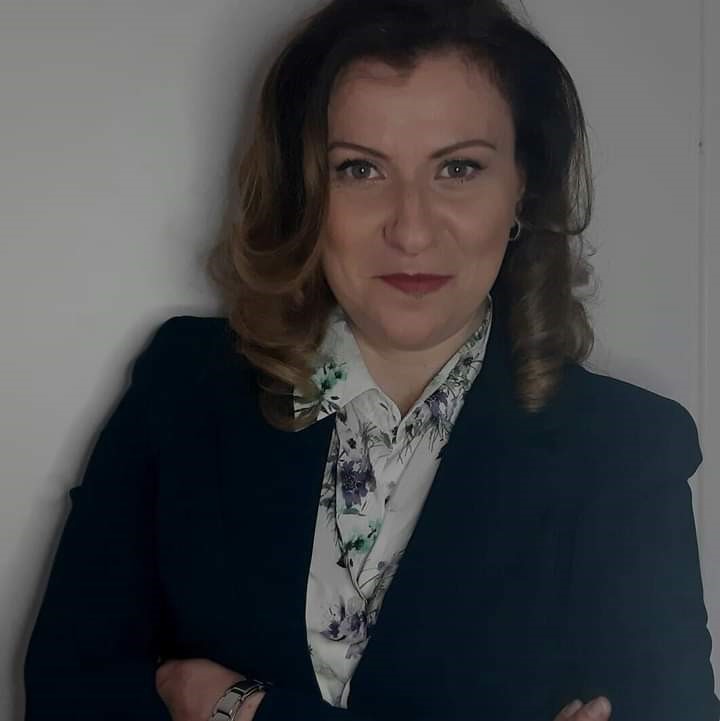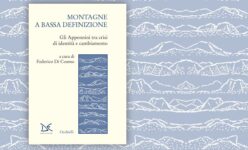D’un alto monte
Valsinni tra storia, archeologia e poesia
Di Rosa Carmen Zaccone
Cuore inerme del nostro stivale, l’Appennino ne segna l’entroterra più profondo, come un ultimo approdo per chi giunge dalla costa o come origine del viaggio di chi dall’interno parte verso terre in apparenza più facilmente abitabili. Oggi quest’antica catena montuosa sembra non ci permetta di coniugare le asperità del suo terreno ai ritmi della modernità, più vivibile verso territori pianeggianti prossimi alla costa o nella piana settentrionale, più adatte ad ospitare grandi città con i loro servizi, contro terreni accidentati dove piccoli borghi ne punteggiano il territorio, tra loro isolati entro ambienti agresti, con dialetti e costumi simili, ma mai uguali.
Eppure la storia del nostro Paese è strettamente legata alla sua dorsale montana più antica, dove i popoli che nei secoli si sono succeduti hanno collocato i loro centri abitati, più riparati e protetti sulle alture rispetto ai centri della costa. Come i Sanniti, che discesi dalla propria terra d’origine alla ricerca di nuove terre da colonizzare, verso la fine del V secolo a.C. giungono in Lucania e ivi fondano centri posti su alture, tra loro visivamente collegati, ed intervallati dalla presenza di fattorie, per creare una grande rete a controllo del territorio. In questo contesto storico si inserisce la fondazione della città su Monte Coppola, centro lucano con una continuità abitativa dimostrata archeologicamente dalla prima metà del IV secolo a.C. alla metà del XIII secolo d.C., data della migrazione degli ultimi abitanti verso il nuovo centro longobardo di Favale, divenuto dal 1873 Valsinni. La genesi del centro alle porte della valle del Sinni si rintraccia così sul Monte Coppola, che sale fino a 890 m s.l.m. e si allarga con timpe e calanchi a delimitare il territorio valsinnese per custodirne una storia secolare, le cui vestigia, antiche e più moderne, ne tracciano materialmente la cronologia. A partire dal castello medievale, dal XVI secolo residenza dei baroni Morra e casa natale della poetessa petrarchesca Isabella Morra, la cui poesia, portata in auge all’inizio del Novecento da De Gubernatis e Benedetto Croce, racconta pezzi della biografia della giovane baronessa e delinea il paesaggio favalese con il racconto del fiume Sinni, visto come una possibile via di fuga verso la Francia, dove il padre, esule, aveva riparato, ed il Monte Coppola, dalla cui altura era possibile vedere quel mare che la fuga avrebbe accompagnato. “D’un alto monte onde si scorge il mare…”, canta Isabella, quello stesso monte che continua ad essere un punto di vista privilegiato su tutta Valsinni, con tracce di un passato archeologico, nei territori rurali, con i suoi “gafi” ed i palazzi signorili del centro storico, ed ancora la Biblioteca e la Pinacoteca morriana del più recente rione Gorga, cardini esemplari della continuità storica di un centro dell’appennino lucano, dove la storia ha lasciato testimonianza viva della sua continuità abitativa, lasciando al presente la necessità di custodirne la memoria ed apprenderne gli insegnamenti che ne permettano la continuità.