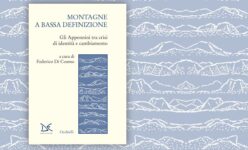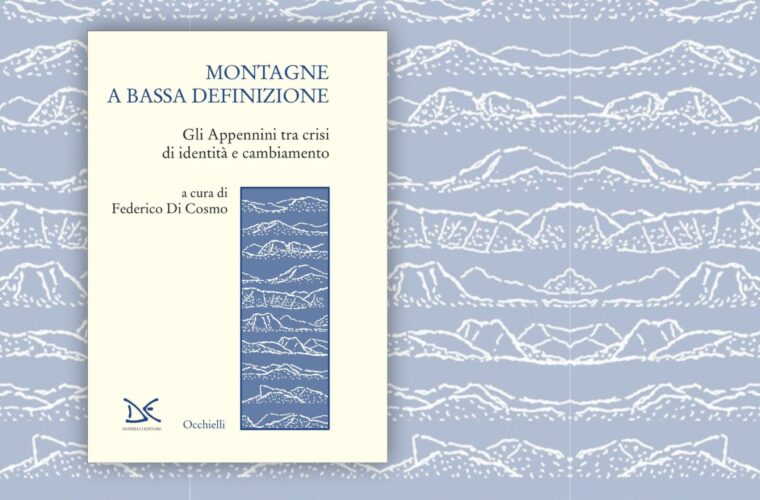A dorso di monopattino
Il monopattino é il mulo della città, ha il dorso su cui si sale e la “capezza” che orienta il cammino. Ha le caretteristiche della economia circolare ma non perfetto fino al punto di avere come dinamo e ricarica un apparato digerente capace di tenere al tempo stesso pulizia e concime per i terreni.
Ma il mulo della città ha qualcosa in più, di diverso: l’uso prevale sulla proprietà.
La condivisione e la collaborazione come pratica di consumo – in particolare nei servizi domestici e professionali, nella finanza, nell’alloggio e nei trasporti – ha un potenziale di mercato, ci dice la Price Waterhouse Coopers (2015), di 570 mld di euro entro il 2025.
Questa opportunità può essere colta prevalentemte nelle aree metropolitane che rappresentano circa il 14% del territorio nazionale con una concentrazione di circa 25 ml di persone ogni giorno (Legambiente 2017), meno nelle aree che, per utilizzare la classificazione contenuta in Riabitare L’Italia (Donzelli 2018 – L’Italia dei pieni e dei vuoti – Cersosimo, Ferrara, Nisticò), rappresentano per minore densità di popolazione oltre il 50% del territorio con circa 25 milioni di cittadini residenti. Qui non c’è il monopattino, inteso come forma di mobilità sharing, e il concetto di proprietà, più che di uso, è rimasto radicato nella cultura popolare: acquisto della casa e della macchina per sé e possibilmente ai propri figli, buoni postali, la cura domestica e professionale sono rispettivamente questione “propria” e di “vicinato”. Questa riflessione non è un ritorno al levismo, perché appare evidente, con tutti i “dispositivi di sicurezza”, che oggi Eboli non è un luogo verso Sud ma anche uno sguardo orientato all’Italia verticale, alle aree interne, alla dorsale Appenninica.
Siamo quindi chiamati a rompere il potere della pigrizia. Se è vero che Eboli – è per me più un punto di separazione tra maggiore e minore densità di popolazione, non solo di distanze tra nord e sud e men che meno di storie o culture minori o maggiori – rappresenta per ragioni geografiche un argine alla diffusione del virus e anche necessario che si introduca qualche vaccino alla pandemia delle pirigrizie e delle consuetudini. C’è bisogno di decisori pubblici e privati, di comunità che siano stimolate e comprendano che forme di collaborazione e di condivisione sono parte fondamentale della nuova civiltà delle macchine: l’innovazione dell’organizzazione sociale può essere utile a sé e agli altri.
E su questo, nel campo della mobilità e non solo, siamo chiamati a fare un salto di qualità, imballati dentro un sistema dei trasporti che cosntrige noi e gli altri ad essere sempre più “marginali” e poco “accessibili”.
Se faccio più smart working ed utilizzo meno la macchina per andare a lavoro anche il concetto di proprietà, come necessità, assume meno forza. E forse inizio a pensare e praticare il valore dell’uso perché più sostenibile economicamente ed ambientalmente.
Questa riflessione – ne ho parlato nell’editoriale di commento all’articolo di Paolo Pileri sulla ‘lentezza” – non si antepone alla necessità di infrastrutturare meglio il Paese. Anzi, siamo chiamati a trovare un equilibrio tra un diritto alla mobilità che riduca disuguaglianze sociali e divari territoriali e una sostenibilità degli interventi che non alterino profondamente la salvaguardia idraulica, paesaggistica e naturale.
Questa pandemia da Covid 19 sta rendendo evidenti tante contraddizioni.
Questa condizione di blocco oggi deve essere pungolo per un futuro migliore. Non possiamo stare fermi.
Senza innovazione le “tradizioni” rischiano di alimentare tanta poesia – e questo non dispiace – e poco futuro. Senza innovazione le “tradizioni” rischiano di scomparire. E fu così che la città trovò il suo mulo, anche lui in fuga dai borghi.