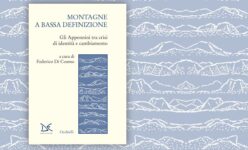L’utopia possibile dell’Appenninomediterraneo
di Piero Lacorazza
Nel libro, in libreria dal 28 marzo, ‘Montagne a bassa definizione. Gli Appennini tra crisi d’identità e cambiamento” (ed. Donzelli), ho messo a terra e in navigazione pensieri su un’utopia possibile: Appenninomediterraneo.
Dal prologo alle coordinate per un’azione politica provo a tracciare una rotta che tende ad indicare una geografia utopica a cui non possiamo voltare le spalle per molto tempo, luoghi a cui dobbiamo mettere un nuovo busto per reggere l’Italia: un Appennino più solido cullato dal Mediterraneo, un’utopia possibile per il nostro Paese.
Questo saggio è il frutto di tante analisi e riflessioni che in questi anni abbiamo fatto, in particolare dal 2019 quando abbiamo voluto chiamare “Appennino” una Fondazione del terzo settore. In quella circostanza decidemmo di registrare nome e marchio con la convinzione che ci venisse respinta la richiesta perché già qualcuno ci aveva pensato prima di noi. Ma con nostra soddisfazione ed orgoglio non c’erano altre esperienze sia nel nome che nella progettualità culturale ed imprenditoriale. Ma non è della Fondazione che vi voglio parlare anche perché per ragioni di opportunità e tempo, e non di incompatibilità, a seguito della mia elezione nel Consiglio regionale della Basilicata, ho lasciato la gestione ritagliandomi lo spazio di co-curatore dei libri della collana che prende il nome della rivista on line civiltaappennino.it di cui sono direttore.
Alla lettura e alla ricerca, al pensiero e alla scrittura provo ad unire lo sguardo e l’impegno istituzionale; la cultura e la politica è la filigrana del mio saggio pubblicato in questo libro.
Sono in ottima compagnia, con autrici ed autori che da anni si occupano di superare l’internità – di cui parliamo nell’ultimo libro “Comunità Appennino, superare l’internità” (Rubbettino, 2024) – e, a questo punto, con la cura, rigorosa e armonica, di Federico di Cosmo, di dare continuità di pensiero e di approccio culturale ad una montagna a bassa definizione”: l’Appennino.
Questa dorsale e colonna vertebrale, come osserva Raffaele Nigro, che lega il Mediterraneo all’Europa e come la ricolloca culturalmente Giuseppe Lupo in una sorta di Medio-Occidente, è “Civiltà Appennino” che nel corso di questi anni ha progressivamente alimentato correnti di pensiero e riflessioni contenute in ben cinque pubblicazioni e centinaia di articoli sulla omonima rivista on line che appunto dirigo da cinque anni.
Oggi, questo libro, pubblicato dalla casa editrice Donzelli, possiamo considerarlo come parte di una battaglia culturale e politica per “Montagne a bassa definizione – non sono le Alpi! – tra crisi d’identità e cambiamento”.
La mia utopia possibile è una mescolanza tra slalom e risalite, cime ed onde, pensiero ed azione, teoria e pratica.
C’è una grande opportunità che l’Italia può cogliere nella dorsale Appenninica; i cambiamenti climatici e la collocazione geo-politica possono essere una straordinaria riserva di futuro, riequilibrando spazi troppo pieni e luoghi sempre più vuoti. Come in altre occasione ho scritto su questa rivista, l’Appennino è anche necessità ed urgenza di lavorare ad una demografia che ci sarà e non solo su quella che vorremmo ci fosse; l’inverno, anche demografico e sociale, potrebbe essere meno rigido e solitario. C’è tanta comunità che cura in Appennino, ci sono paesi che possono essere certificati ed ottenere una “bandiera d’argento” e valorizzare tutto il potenziale – anche per creare posti di lavoro – della Silver Economy.
L’Italia ha bisogno di politiche industriali, di investire in ricerca e formazione, di collegamenti, di ridurre divari e rendere esigibili i diritti di cittadinanza per tutte e tutti. Non sfugge il contesto geo politico, economico e commerciale e siamo consapevoli che non saranno le sole idee “romantiche e bucoliche” a risollevarci dalle condizioni in cui siamo. Serve la poesia, cosi come la scienza.
C’è anche un modello che risulta insostenibile e negarlo, o pensare di essere indifferenti, non è etico ed utile.
Il prezzo che si rischia di pagare può essere molto alto, in considerazione anche degli investimenti da fare ora. E allo stesso tempo è necessario cogliere le opportunità che possono essere messe in moto da politiche pubbliche, cittadini ed imprese per trasformare la sostenibilità in un processo economico e sociale capace, anche, di produrre buone relazioni e comunità.
Mettiamola cosi: pagarsi – chi può permetterselo – la migliore sanità o la migliore scuola per i propri figli che vivranno in un mondo peggiore a cosa serve? Oppure avere politiche pubbliche che sostengano una industria che rispetta gli ESG – obiettivi ambientali e sociali – in un mercato di dazi e guerre commerciali può essere sufficiente?
È chiaro che senza perdere il punto vista generale è necessario fare analisi e valutazioni che aiutino a rendere più robusta una idea di sostenibilità, a reggere il peso del futuro e tenere l’Italia dritta, in piedi ed unita; e in questo l’Appennino, luogo e metafora, è la colonna vertebrale che può aiutare.
E alla luce del dibattito attuale sul futuro del “vecchio continente” resta per noi fondamentale la postura letteraria di Raffale Nigro che individua nell’Appennino l’ascissa terrosa e floristica che lega l’Europa al Mediterraneo; una linea mediana, per dirla con le parole d Giuseppe Lupo, che potrebbe indicare un Oriente non ancora occidentalizzato e/o un Occidente rimasto ancora un poco orientale; l’Appennino sarebbe così un medio-occidente.